
Ragusa Sottosopra - Anno XII - N° 2
Itinerari
Maschere, putie e loca ri perdizioni
Una passeggiata tra suggestioni carnascialesche e le testimonianze di uno spirito comunitario che non disdegna il piacere dell’osteria e delle case chiuseEsiste una dimensione comunitaria anche nel vizio? Ma il carnevale è da considerarsi una festa del vizio?
La rivalsa della carne nei confronti della spiritualità cristiana? Certamente il nome non si giustifica, se non in
rapporto alla Quaresima cristiana; esso indica il periodo che precede la Quaresima, durante la quale si doveva lasciare la
carne, “carnesciale”, dal latino medievale “carnem laxare”. Non una bacchica esplosione di gioia, ma piuttosto il rimpianto,
alla vigilia delle Ceneri, dell’abbandono dell’uso della carne, “Carnesciale” è voce, perciò, più vicina all’idea della
morte, che a quella delle baldorie.
E il termine “sdirri”, storpiatura siciliana del francese dernier, vale per gli ultimi giorni
del carnevale: la “sdirruminica”, “lu sdirriluni, e lo “sdirrimarti” la sera appunto del martedì, la “sdirrisira” per
eccellenza, la serata d’addio alla carne, l’ultimo banchetto prima della morte, e non solo dei sensi. E “la morte” veniva
chiamata una pezzuola intagliata a forma di teschio, abbondantemente impolverata di gesso legata ad un laccio che durante il
carnevale noi bambini con destrezza lanciavamo sui neri “scialli” delle “femmine ri casa” e con maggior gusto se “fighie ri
Maria” o beghine, all’uscita della chiesa sul sagrato di San Giovanni, “'na piazza de logghi”, lasciandovi una lattiginosa
impronta di morte.
Strana caratteristica dell’anima siciliana il non sapere concepire gioia di vita se non in relazione al suo termine, per cui
la più poetica delle sue tradizioni, la più religiosa, foscoloniamente intesa, è certamente quella dei “murticieddi”, in cui
gli spiriti dei nostri cari, “lari o padri del focolare domestico” piuttosto che anime del purgatorio, scendono nel mistero e nel buio della notte a dispensare ai “fighiuli” le più belle gioie della natura, dalla frutta secca alle meravigliose
melagrane, “i ranati”, carichi di straordinari significati simbolici dell’amore all’apparenza tanto più diabolici, quanto più rossa ne è la traslucida buccia qua e là spaccata dall’intimo turgore. Per quelli che potevano permetterselo, c’era tutta
l’altra frutta fuori di stagione sapientemente plasmata da virginee mani monacali nella meravigliosa
frutta martorana.
Cosa di più umano della solidarietà dinanzi alla morte, solidarietà di cui è simbolo “u cuonsulu”, il banchetto funebre che riunisce tutti i parenti del defunto; solidarietà che caratterizza il banchetto della “sdirrisira” a cui non può
sottrarsi chi ai suoi si sente legato da vincoli di parentela, di amicizia, di comparatico.
La sdirrisira falla ccu li tuoi”
Cammararsi nei giorni di carnevale, vale a dire mangiar carne nei giorni di astinenza, rompere il digiuno “prima della morte” non solo non costituisce peccato, ma diventa addirittura segno di vincolo amicale, a cui nel ragusano veniva dedicata la vigilia del giovedì grasso, “u iovi ro lardaruolu”; ed era “Lu miercuri di lu zuppiddu”:
ccui nun si cammira è pieu pir iddu”
È peggio per lui, perchè peggio dell’inferno è la solitudine.
Meglio in inferno con “poveri diavoli” che in paradiso da soli “unu sulu nun è buonu mancu n’ parádisu”.
E “u Zuppiddu” (lo zoppetto) non era altro che un povero diavolo che aveva in comune coi contadini della Contea la mala sorte di dover sottostare alle vessazioni e alle “supercerie”, quelle del barone padrone e del becero campiere e queste del padrone dei diavoli o “Lu Cifru” (Lucifero) e dell’Arsu Cani (Cerbero). Lo “Zuppiddu” con la sua claudicante debolezza era infatti destinato, insieme ad altri tre poveri diavoletti, al servizio del tirannico padrone e del suo Cerbero. E tutti e quattro, perciò, venivano chiamati coll’affettuoso diminutivo VARVARIEDDU, MAZZAMARIEDDU, ‘NTANTIDDU.
Ma di tutti il più festoso, quello che più sprizza gioia di vivere, è appunto “lu Zuppiddu”, forse l’unica
maschera documentata del carnevale della Contea di Modica; in tutto coincidente con il pagano satiro Sileno, che alla corte di Bacco danzava bellamente, anche se zoppo, sulle sue zampe caprine.
Ma si sa “ch’è checchi” (balbuzienti) nun cantari e ch’è zuoppi nun ballari”.
Narra infatti Serafino Amabile Guastella, nel suo “Antico Carnevale nella Contea di Modica”, che nella sua infanzia, insieme ad altri compagnetti, andò in visita da una anziana donna, che tirò fuori da una cassa “una maschera rossa ghignante con corna caprine intrecciate con festoni di edera cui associò una stampella intagliata a fiaschi, teste caprine e grappoli d’uva e altri emblemi bacchici”, e disse che era la maschera dello “zuppiddu”. La stessa maschera burlesca e irriverente, intessuta di elementi vegetali, per lo più di acanto, è ricorrente alla base dei mensoloni dei nostri balconi barocchi.
Proveniente dalla tradizione del teatro dei burattini di Palermo e dalla recitazione teatrale che da esso derivava con il
nome di “vastasati”, accanto a vari altri personaggi v’era anche quello interpretato senza maschera del “Barone”, che nei nostri paesi era stato trasformato poi in “Piscia calamaru”, corrispondente all’azzeccagarbugli manzoniano, così descritto in
una vivace ottava dell’analfabeta poeta chiaramontano Paolo Spada:
Ca si ni veni ccu ssa nàsca tranti?
Tantu ca tantu ’un avi chi mi fari,
Ca m’ha misu la facci a lu livanti.
Prima vosi ‘na coscia ri maiali,
Pui l’uoggiu, pui lu vinu ri li cianti;
Ora ca ‘un avi cciù chi raciuppiari,
Passa tisu e mi rridi ppi davanti.
Altro tipo carnevalesco era Don Serpentino, una sorta di smargiasso Miles Glorioso
Ca cc’un pugnu sdirrubbu li castedda;
Muncipieddu lu spriemu ppi lumia,
Piggiu a Mauta (Malta), e la jiettu ppi cciappedda
Ma sientu un pirituozzu... Mamma mia!
Mi staiu cacannu tutti li vuredda.
Insomma Don Serpentino corrisponde a “Capitan Spaventa” o “Fracassa”. Altri tipi particolarissimi della Contea erano lu “Zu’Rusà” (zio Rosario) e l’ “Allampacucchi” o “Màsciu Ruppìddu”. Lo “Zu’Rusà” vestiva un lercio “santammarcu”, abito tra la casacca e il mantello, il berretto a mortaio, calzari e brache e “robone” di pelo. Era il villano attaccato alla roba oltre ogni immaginazione e sentimento:
Lassàtimi lu sceccu, ca mi campa,
E piggiàtivi scanciu lu figgiùlu,
Ca ppi tri ggiorna v’addumu ‘na lampa.
Era il tipo che la “mastranza” aveva escogitato per rappresentare i villani, i quali a loro volta avevano inventato “ l’Allanpacucci o Mastru Ruppiddu”. Quanto quello era grossolano e stupido, tanto costui era astuto, bugiardo, truffatore, ladro. Indossava la classica “caella”, una “polacca” di cuoio: ma tutto era finto, i merletti della camicia erano di carta ritagliata, le brache erano tinte alla meno peggio, i buchi delle scarpe erano rattoppati con cera. Era così canagliescamente opportunista da essere delatore del padre ricercato dagli sbirri, per aver sparlato contro i giurati:
Vi l’attaccu, e lu puortu a lu Castieddu:
E bbui, Patruzzu miu, nu’ bb’allagnati.
Bon bon’è, m’abbuscu un carrinieddu
(un carlino, una monetina di poche centesimi).
Una specie di repellente befana era “la Vecchia di li fusa”, una reliquia delle parche che filano il filo della vita e per cui i fanciulli che la inseguono esprimono il tentativo di strapparle il fuso e la rocca, onde allungare i giorni del
Carnevale che sta per morire e non soltanto di quello.
Le riflessioni sullo spirito solidaristico del nostro carnevale indottemi dalla rilettura dell’opera di Serafino Amabile Guastella mi sono parse quanto mai pertinenti a indicare la perdita di senso comunitario che da qualche
tempo subisce il nostro centro storico di Ragusa superiore. Nulla di più eloquente del silenzio di ogni festa, dell’assenza di quelle
iniziative creative di eventi e sfilate allegoriche che negli anni del secondo dopoguerra animarono i carnevali ragusani per merito del circolo universitario Turati, con l’apporto creativo dell’artista Peppino Cascone, e in tempi più recenti di iniziative più modeste sia pure parrocchiali. Era quindi consequenziale la decisione del Laboratorio di Urbanistica
partecipata “Insieme in Città” di farne il tema di una passeggiata da effettuare il pomeriggio della “Sdirruminica”, lungo la quale ammirare i mascheroni dei nostri balconi barocchi. Il tema si prestava inoltre a una rassegna delle osterie o bettole e dei luoghi di perdizione, ovvero alle case di piacere o di tolleranza.
“Maschere, putié e loca ri perdizioni” è stato il filo conduttore della passeggiata effettuata il 19 febbraio scorso in concomitanza con le manifestazioni organizzate dal Comune, in collaborazione con soggetti privati, che ha visto fra l’altro l’interessantissimo laboratorio di maschere e mascheroni di Mariella Vero in cui sono state realizzate, con materiale di riciclo, maschere ispirate ai mascheroni barocchi, fra cui quella dello Zuppiddu. E a proposito, un momento particolarmente interessante della passeggiata è stato quello della contemplazione del ciclo di sculture dei balconi del palazzo Melfi, oggi Zacco.
Si può infatti ragionevolmente ipotizzare una lettura delle sculture della facciata occidentale su via San Vito in chiave carnevalesca. Già Oscar Spadola aveva notato l’irriverenza di un mascherone alla base di un mensolone prospiciente la chiesa di San Vito (Oscar Spadola, Balconi del Settecento , Rotary Club Ragusa 1982, pp. 14-21): “Questo mascherone, così degenere da acquisire sembianze animalesche (e perchè non
pensare a un satiro e allo stesso Zuppiddu), mostra da secoli sconciamente a tutti la lingua con ludibriosa compiacenza. Posto così bene in vista, proprio dinanzi alla porta della chiesetta, diviene per di più
insopportabilmente sacrilego per la ripetizione buffonesca di chi si appresta, con la bocca aperta, a ricevere l’ostia
consacrata.
Tale pezzo dall’atto così provocante fu messo di proposito? L’ipotesi è suffragata da una anomalia riscontrata
nel contesto compositivo dell’insieme della stessa facciata. Il balcone dei musici, infatti, posto lateralmente a sinistra di quello principale nell’ingresso, ha il mascherone della mensola centrale volto pure a sinistra. Per simmetria compositiva il mascherone della mensola centrale del balcone di destra avrebbe dovuto avere il volto rivolto a destra. La scultura, invece, non solo è stata realizzata frontalmente ma con una azione che nell’altro manca del tutto, esce la lingua, per lo meno con volgare irriverenza. È il mascherone davanti la chiesa”.... “Ma tutta la facciata principale del palazzo sulla via San Vito... è completata dalla invadente sporgenza di due balconi impiantati lateralmente al portale d’ingresso... (Essi)... si rendono invero attraenti per i vezzi e per i personaggi rappresentati...una baraonda di musici, forse giocolieri, spadaccini e mascheroni, taluni dei quali dalla faccia canesca, talmente movimentati da sembrare colpiti all’improvviso, nel pieno di una fantasia carnascialesca, da una bacchetta magica uscita fuori, non si sa come, da una favola da Mille e una notte, con il potere satanico d’averli tramutati in dura pietra, e nelle pose più strane, sotto i balconi. Una muta baldoria pietrificata di tanti individui con flauti, clarinetti, piccole trombe maracas, sembra animarsi ancora in una festa carnevalesca, tanto più sfrenata, quanto più consapevole di essere l’ultima prima della Quaresima tanto più blasfema, quanto più prossima all’incombente penitenza del sacro”.
Allo stesso spirito comunitario cui fan riferimento i versi vernacolari e i mascheroni carnevaleschi, sono improntate le gran bevute in Osteria, solo gli alcolizzati bevevano da soli, e le iniziazioni al sesso che avvenivano in profane processioni alle “case chiuse”, da noi volgarmente chiamate “casini”. In tutta Ragusa nell’anteguerra (alla data del 1935) erano registrate 52 fra bettole e osterie e di queste ben 34 a Ragusa Superiore, contro la decina di Ibla; il resto era distribuito fra contrade e frazioni.
Nelle parrocchie di San Giovanni e Santa Maria delle Scale, il cui territorio è oggetto della nostra visita, ve n’erano ben 23, sparse un pò in tutte le vie, ma con una particolare concentrazione nel quadrilatero compreso fra la via S. Francesco e la via S. Anna e fra la via Antoci (attuale G. Matteotti) e la Cav. Distefano.
Manco a dirsi la parte del leone la faceva “u tunnu e’putìe” e “u buccagghiu ‘o ponti” o boccaglio del ponte,
dove le osterie si susseguivano porta per porta.
Una buona metà di queste bettole erano gestite da donne, che nel dopoguerra riciclarono l’attività in esercizi alimentari a seguito del progressivo calo del consumo di vino in osteria. È il caso ad esempio di donna Vannina a Caliara (Giovanna Di Falco) che esercitò la vendita di alimentari fino agli anni ‘50, al n. 102 di via Sant’Anna, dove nell’anteguerra aveva un’osteria.
Generalmente i rivenditori o rivenditrici erano titolari di due esercizi, uno adibito a osteria, un altro alla sola vendita, evidentemente perchè una certa clientela non gradiva di andare ad acquistare il vino per l’uso domestico in una bettola frequentata da ubriaconi. Così è per don Ducezio Distefano che aveva la bettola in via Angelo Majorana (attuale via Criscione traversa fra via Matteotti e via Rapisardi), ma la rivendita in via Ecce Homo, di fronte al cinema Marino.
Donna Leonarda Vasta era proprietaria di due esercizi, uno in via S. Anna e un altro in via Rosa, al n. 8, all’angolo con la via Nunzio Nasi (attuale Corso Vittorio Veneto).
L’Oste Giovanni Frasca aveva l’osteria al n. 13 di via Ponte (attuale via Angelo Majorana), ma aveva anche la rivendita nella stessa via al n. 54.
Le ultime osterie sopravviveranno in via San Sebastiano e nei pressi fino agli anni 60, quando furono scalzati dai numerosi bar e ristoranti sorti nella zona a seguito del balzo economico e sociale dando corpo alle aspettative suscitate dalla scoperta del petrolio in contrada Pendente.
Sopravviveranno i rivenditori di vino all’ingrosso come i Mazza e i Piccitto.
“U tunnu ‘e putie” e “u buccaghiu o ponti” come era più nota via Ponte non godevano buona fama, non solo per la presenza di numerose bettole ed osterie, ma soprattutto perchè dalle scale della discesa di via Mario Rapisardi e dalla Discesa Santa Maura si perveniva ai “Casini”, quelli più popolari: i più pretenziosi erano collocati a Nord, “a serra”, cioè lungo la via Armando Diaz, mascherati da alberghetti, come il “Ragno d’Oro” o da pensioncine come quelle di Susanna o di Tiziana.
Dei casini delle discese alla Cava di Santa Domenica numerosissimi, e generalmente non autorizzati, fra i pochi ufficiali e soprattutto il casino più famoso e più frequentato (anche per l’accessibilità del costo delle prestazioni) era “u casinu ra za Marietta” gestito da due sorelle, “Marietta”, appunto, e Antonella, più generalmente note come “i suoru sticchimi, stocchimi”, per l’andatura esageratamente ancheggiante.
La zia Marietta si avvaleva della collaborazione di “u zu Papè”, un tipetto saltellante come lo zuppiddu, che, dice Mimì Arezzo, pubblicizzava la bontà delle merci, ripetendo il ritornello:
Viniti, accianati
Ca na beda picciotta c’è.
Le “case chiuse” autorizzate erano tenute al controllo medico delle prostitute, che venivano accompagnate in carrozza in ospedale per la prescritta visita medica da un certo Turiddu Parabaddi, il quale le trasportava altresì quando per il cambio della “quinnicina” portava le nuove ragazze dalla stazione con grande esibizione e scandalo su una carrozza scoperta.
E rimanendo alla domanda iniziale se esiste una dimensione comunitaria anche nel vizio, la carrozza esibita da Turiddu Parabaddi ne è la più evidente risposta affermativa.
Autore: Giorgio Flaccavento
Commissione Risanamento Centri Storici:
Opinioni a confronto:
L'opera:
Il recupero:
Lavori in corso:
Palazzi storici:
Ambiente:
Itinerari:
Beni mobili:
Congressi:

























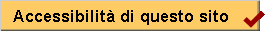
Aggiungi questo link su: