
I monumenti del tardo barocco di Ragusa
I 18 monumenti riconosciuti dall'UNESCO
Chiesa di San Giorgio
La chiesa di San Giorgio, antica chiesa madre della città, prima del 1693, sorgeva all'estremità est dell'abitato,
 nei pressi dell'attuale Giardino ibleo, dove si trova ancora il grande portale
quattrocentesco, di stile gotico-catalano, unica vestigia rimasta dell'antico tempio.
nei pressi dell'attuale Giardino ibleo, dove si trova ancora il grande portale
quattrocentesco, di stile gotico-catalano, unica vestigia rimasta dell'antico tempio.
La chiesa venne infatti gravemente danneggiata dal terremoto: restarono in piedi parte della facciata, alcune
cappelle e parte della Cappella maggiore, per cui venne costruito un ampio locale adiacente alla navata sinistra del
vecchio tempio, in cui poter svolgere le sacre funzioni.
Nel secondo quarto del secolo XVIII, si pensò al trasferimento della chiesa in una posizione piu' centrale rispetto
all'abitato, e, dopo aver scartato l'ipotesi di una ricostruzione nel sito della vecchia chiesa di S. Giovanni,
anch'essa trasferita, si decise di costruirla al posto della chiesa di S. Nicola, che fino al secolo XVI era stata la
parrocchia dei fedeli di rito greco e successivamente, passata al rito latino, era divenuta "chiesa sacramentale
" di S. Giorgio.
Del progetto della nuova chiesa venne incaricato, nel 1738, Rosario
 Gagliardi, architetto della città di Noto e del suo vallo, uno dei protagonisti della
ricostruzione barocca, che in questo edificio ci ha lasciato, forse la sua opera migliore. La prima pietra del nuovo
tempio fu posta il 28 giugno dell'anno successivo, come ricorda una lapide murata sul lato destro della scalinata, e
tuttavia, come ricorda l'enigmatica iscrizione posta sul lato opposto, i lavori poterono cominciare solo nel 1744,
probabilmente a causa dell'opposizione dei procuratori della chiesa di S. Nicola, che non volevano perdere il loro luogo
di culto.
Gagliardi, architetto della città di Noto e del suo vallo, uno dei protagonisti della
ricostruzione barocca, che in questo edificio ci ha lasciato, forse la sua opera migliore. La prima pietra del nuovo
tempio fu posta il 28 giugno dell'anno successivo, come ricorda una lapide murata sul lato destro della scalinata, e
tuttavia, come ricorda l'enigmatica iscrizione posta sul lato opposto, i lavori poterono cominciare solo nel 1744,
probabilmente a causa dell'opposizione dei procuratori della chiesa di S. Nicola, che non volevano perdere il loro luogo
di culto.
Al Santo Vescovo venne poi intitolato l'altare del transetto destro che probabilmente è posto nel luogo in cui
sorgeva l'altare maggiore dell'antica chiesa.
Il progetto del Gagliardi, di cui si conservano ancora le tavole originali, è caratterizzato dalla monumentale
facciata "a torre" che ingloba il campanile nel prospetto e termina con una cuspide a bulbo, richiamando i
tabernacoli lignei, seicenteschi, delle chiese cappuccine.
La sua collocazione, al termine di un'alta scalinata, e la posizione obliqua rispetto alla piazza sottostante ne
accentuano l'impotenza e gli effetti plastici, creati da una lieve convessità del partito centrale e dalla presenza delle
colonne libere.
Due coppie di volute fanno da raccordo tra i diversi livelli ospitando, rispettivamente, le statue di S. Giorgio e
San Giacomo, in basso, e quelle di S. Pietro e S. Paolo, in alto. Sulla cuspide, sotto la croce, si legge la data 1775, che
indica la conclusione dei lavori della facciata, avvenuta il 5 ottobre di quell'anno con la "salita" delle
campane.
Nel primo ordine del partito centrale si apre un grande portale con la cornice mistilinea, ricca di fregi e rilievi a
motivi vegetali, mentre le porte lignee hanno una preziosa decorazione scultorea, in sei riquadri, con la raffigurazione di
episodi del martirio di San Giorgio, opera dell'intagliatore palermitano Vincenzo Fiorello, che li realizzò nel 1793.
L'interno, a croce latina, con le braccia chiuse da absidi semicircolari, è sereno ed equilibrato e viene diviso in
 tre navate da dieci robusti pilastri in pietra, con un'ampia zoccolatura in pece.
Gli intagli che decorano il cornicione e i capitelli dei pilastri furono realizzate tra il 1779 ed il 1781, dagli
scultori Giambattista Muccio e Giorgio Nobile di Ragusa. Nell'incrocio del transetto con la navata centrale si eleva la
cupola, di gusto neoclassico, a doppia calotta, poggiante su due file di colonne.Secondo la tradizione sarebbe stata
progettata e realizzata, nel 1820, dal capomastro ragusano Carmelo Cultraro, ispirandosi alla cupola del pantheon di
Parigi, tuttavia recenti studi e riscontri archivistici ne assegnano la paternità all'architetto Stefano Ittar.
tre navate da dieci robusti pilastri in pietra, con un'ampia zoccolatura in pece.
Gli intagli che decorano il cornicione e i capitelli dei pilastri furono realizzate tra il 1779 ed il 1781, dagli
scultori Giambattista Muccio e Giorgio Nobile di Ragusa. Nell'incrocio del transetto con la navata centrale si eleva la
cupola, di gusto neoclassico, a doppia calotta, poggiante su due file di colonne.Secondo la tradizione sarebbe stata
progettata e realizzata, nel 1820, dal capomastro ragusano Carmelo Cultraro, ispirandosi alla cupola del pantheon di
Parigi, tuttavia recenti studi e riscontri archivistici ne assegnano la paternità all'architetto Stefano Ittar.
Nelle cappelle delle navate laterali si trovano tele dei migliori artisti del settecento siciliano: D'Anna, Tresca,
Manno; sopra le porte laterali sono conservati i due simulacri che vengono portati in processione per le strade , durante
la festa patronale di San Giorgio: la statua del Santo a cavallo opera dello scultore palermitano Bagnasco, che la
realizzò nel 1874, e la grande cassa-reliquiario in lamina d'argento sbalzata, opera del 1818, dell'argentiere palermitano
Domenico La Villa.
Sulla navata centrale prospetta il grande organo (1887) a 3368 canne, capolavoro della ditta "Serassi" di
Bergamo, che lo volle chiamare "Organum maximum", in quanto sintesi della sua migliore arte organaria.
Nell'adiacente sacrestia si conserva un resto della monumentale ancona in pietra calcarea che lo scultore Antonino Gagini
aveva scolpito per la vecchia chiesa di San Giorgio tra il 1573 e il 1576. Dalle rovine della chiesa furono recuperate
tre nicchie e quattro statue che, pur assemblate in modo alquanto scorretto, danno tuttavia una idea della magnificenza
dell'opera originaria.
I testi e le immagini sono state estratte dal libro: "I Monumenti del Tardo Barocco di Ragusa"
per gentile concessione della T.N.G. srl - NONSOLOGRAFICA.
Le foto sono di Francesco e Stefano Blancato, i testi di Giuseppe Antoci I diritti di autore sulle immagini
e sui testi sono di esclusiva proprietà della - NONSOLOGRAFICA srl -
Ne è vietata la riproduzione sistematica, anche parziale, con qualsiasi mezzo.
Per informazioni rivolgersi a:

NONSOLOGRAFICA srl -Via Natalelli, 40 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.654898, Fax 0932.652000
www.nonsolografica.net










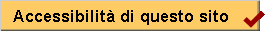
Aggiungi questo link su: