
Castello di Donnafugata
Donnafugata: masseria fortificata, casina neoclassica, castello neogotico, riflessioni su una mutazione
Le medesime considerazioni si possono fare per l'esterno: esistono degli elementi decorativi riconducibili al progetto
neoclassico,
 che nei dipinti del castello sono tratteggiati in fase di costruzione.
Si guardino ad esempio i piloni con specchiature a rincasso sormontati da vasi di gusto classico che ritroviamo
all'inizio del percorso d'accesso e in quello che doveva essere l'ingresso al giardino dalla strada, prima che venisse
aperto quello neogotico.
che nei dipinti del castello sono tratteggiati in fase di costruzione.
Si guardino ad esempio i piloni con specchiature a rincasso sormontati da vasi di gusto classico che ritroviamo
all'inizio del percorso d'accesso e in quello che doveva essere l'ingresso al giardino dalla strada, prima che venisse
aperto quello neogotico.
Si notino i fregi a ghirlanda con stemma araldico sui fronti del viale centrale, o l'insegna affiancata da due
coppie di leoni accovacciati che sormonta l'attico della stessa casina dipinta: tutti i particolari che rimandano agli
elementi decorativi del Casino di Conversazione di Ibla, commissionato anch'esso dagli Arezzo.
A
 Donnafugata si assiste ad un processo di commistione dei caratteri distintivi dell'architettura vernacolare iblea.
Donnafugata si assiste ad un processo di commistione dei caratteri distintivi dell'architettura vernacolare iblea.
L'edificio principale posto al centro si erge su un basamento, la cui preesistenza al castello è accertata da
nuove acquisizioni documentali e dal materiale iconografico di cui disponiamo. Questa peculiarità fa sì che il
complesso si ponga al visitatore con la duplice valenza di roccaforte, in posizione dominante rispetto ai declivi del
territorio circostante, e di recinto che delimita a scopo difensivo l'intera struttura produttiva.
Emerge infatti dai documenti che in origine gli animali, il tappeto, i magazzini per la conserva del raccolto
trovavano alloggio all'interno di questo corpo basamentale che, in seguito alle trasformazioni ottocentesche, verrà
privato della funzione produttiva mantenendo esclusivamente quella di servizio agli ambienti residenziali del castello.
Vi troveremo infatti la cucina, la dispensa e la cappella, traslata solo in un secondo tempo sul fronte principale, su
cui si aprirà con un ingresso autonomo rispetto a quello del cortile interno, in modo da permetterne la fruizione al
personale di servizio che alloggiava nella corte e agli abitanti del borgo adiacente.
Si assiste pertanto ad una progressiva trasformazione del complesso da rurale e quindi meramente produttivo, a casina di
campagna che mantiene al suo interno parte degli ambienti funzionali, per l'emergere sempre più incisivo dell'istanza
di rappresentatività, leggibile, oltre che nella cura del dettaglio decorativo, anche nei progressivi cambiamenti nella
destinazione d'uso degli ambienti.
Che il nascere della corte semicircolare antistante il fronte principale del basamento sia dovuto ad un disegno
astratto e non ad una naturale trasformazione della facies del complesso per motivi funzionali, è dimostrato dal fatto
che il percorso centrale che conduce alla corte è già definito anche quando gli edifici che vi si attestano lo sono
ancora solo in parte. Ne troviamo conferma nella prima delle due vedute della Sala della Musica dove compare il medesimo
muretto basso che delimita il giardino affiancato da uno solo dei caseggiati rurali. Allo stesso modo, da una tela che
si conserva al castello si evince la preesistenza del tracciato dei muri e dei piloni d'accesso.
Questo elemento induce a porre l'attenzione sui possibili modelli iconografici che ci sembrano l'unica spiegazione
plausibile a questa rara caratteristica del complesso rispetto alle architetture rurali o alle casine di campagna
presenti in area iblea.
La tipologia più diffusa nella zona è come si è detto quella comune a tutto il territorio insulare, cioè la
masseria cintata a più corpi edilizi.
Per quanto riguarda le ville signorili il modello è quello rinascimentale ad unico blocco d'aspetto compatto e
imponente.
In nessuno di questi edifici però è presente il sistema del percorso d'accesso tra i muri che delimitano il
giardino e vi aprono quasi un varco che conduce alla corte semicircolare costituita dai corpi bassi. Questa è invece
una peculiarità delle ville palermitane del Settecento, che è probabile abbiano costituito un modello di riferimento
per il primo progetto neoclassico di Donnafugata.
pag. 3
Tutto il materiale è tratto dal testo "Donnafugata il castello" edito da: Filippo Angelica Editore
I testi sono a cura di: Carmelo Arezzo, Gaetano Cosentini, Milena Gentile, Biagio Guccione, Giacometto Nicastro
Le schede Botaniche sono di: Tiziana Turco Le Foto di: Giuseppe Leone
Si ringraziano l'editore e gli autori per la gentile concessione










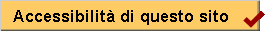
Aggiungi questo link su: