
Ragusa Sottosopra
n.6 del 30/11/2011
I monumenti ai caduti della grande guerra
Antonio Romano, Storico dell'arte

Tra le varie tipologie di monumenti ai caduti eretti nel territorio ragusano quella più ricorrente è il cenotafio
Il centro storico di Ragusa mostra allo sguardo di chi lo vive quotidianamente un patrimonio storico-artistico variegato, in cui coesistono diverse tipologie di beni culturali, spesso poco conosciuti forse per la loro scarsa valorizzazione. In particolar modo, risultano essere poco considerati i monumenti ai caduti della Grande Guerra, che, in questa come in altre città, vennero costruiti con ampio consenso per ricordare e onorare le numerose vittime militari italiane.
I monumenti ai caduti rivestono la duplice e importante funzione di monumento-documento; essi sono espressione di determinate caratteristiche estetiche indotte dagli esiti della statuaria e dell'architettura del tempo, ma soprattutto, come in questo caso specifico, si possono considerare dei fondamentali documenti storici di un periodo importante della nostra storia nazionale.
Oltre ad avere questa significativa funzione, per alcuni studiosi i monumenti ai caduti furono un preciso aspetto di costume, tutto italiano, volto all'autocelebrazionismo nazionalistico e alla retorica dell'eroismo per nascondere frustazioni di provincialismo e attese inappagate. Si pensa che la loro costruzione rappresenti il senso di colpa per non essere riusciti a garantire taluni degli obiettivi per i quali i soldati si sacrificarono e, per questo motivo, istituzioni e politicanti dell'epoca si assunsero il compito riparatore di innalzare queste architetture commemorative.
Il culto del soldato caduto risale alle guerre della Rivoluzione francese e alle guerre di liberazione tedesche; esso nasce nelle trincee dove si forma la “comunità dei compagni”. Inizialmente tale culto è il ricordo dei compagni e la necessità di trovare risposte sul perché si muore. Si muore per la patria, per il senso del dovere, per l'unità nazionale e per l'obbedienza. Di conseguenza nasce la forte esigenza di costruire tombe e piccoli “monumentini”
Sappiamo che fino a tutto l'Ottocento i morti in guerra, per ferita o malattia, venivano sepolti dove capitava, nei cimiteri vicini e spesso in fosse comuni. Nel dopoguerra, invece, alcuni di questi poveri corpi venivano restituiti alle famiglie per essere seppelliti nei vicini cimiteri civili, mentre la maggior parte era destinata a cimiteri ben organizzati, ad ossari e monumenti di grandi dimensioni voluti dal regime fascista come glorificazione e appropriazione della guerra.
Nel territorio di Ragusa tra le varie tipologie di monumenti ai caduti quella più ricorrente è il cenotafio, ossia un'architettura commemorativa che non funge da sepoltura, ma ha soltanto la funzione di celebrare e onorare i soldati morti in guerra.
Il monumento artisticamente più rilevante è sicuramente quello ubicato nel pieno centro della città settecentesca, precisamente sul sagrato della Cattedrale di San Giovanni, accanto alla facciata. Altri due monumenti ai caduti si trovano all'interno del giardino ibleo, nell'antico quartiere di Ibla, e nella borgata marinara di Marina di Ragusa in piazza Torre.
Nel 1921 a Ragusa superiore, ancora divisa amministrativamente da Ibla, il ricordo della Grande Guerra è molto vivo e in questo clima post-bellico alcuni cittadini propongono di erigere un monumento per ricordare i ragusani caduti per difendere la patria. Il monumento viene realizzato grazie ad un raccolta di fondi e ad una lotteria promosse da un apposito comitato composto da persone influenti.
La sua costruzione
L'opera fu inaugurata il 12 maggio 1924 da Benito Mussolini in persona, durante la sua prima visita a Ragusa. Il monumento, interamente rivestito in marmo, si sviluppa in verticale, mostrando una composizione architettonica costituita inizialmente da un alto e largo basamento sul quale si impostano tre gradini che successivamente vanno a restringersi verso l'alto. Subito dopo insiste un deciso piedistallo che sostiene il gruppo scultoreo in bronzo.
Nella parte retrostante chiude l'intera composizione una struttura liscia, conclusa da una cornice marcapiano e da una coppia di piccole volute laterali. Sui gradini è posta una corona d'alloro in bronzo, simbolo di gloria e trionfo, e sopra di essa una lapide recita “Ragusa ai suoi figli caduti per la Patria sempre vivi nel cuore di tutti i fratelli italiani”.
Significative risultano le pareti verticali del piedistallo in cui sono incisi “a carattere d'oro e di fuoco” i nomi dei numerosi caduti ragusani; evidentemente i caratteri d'oro e l'incisione a fuoco simboleggiano rispettivamente l'importanza e l'eternità dei caduti stessi. Infatti, con la prima guerra mondiale, i monumenti, in cui precedentemente comparivano soltanto i nomi degli ufficiali, cessarono di essere anonimi e su di essi vennero incisi tutti i nomi dei singoli soldati caduti. In questo processo di democratizzazione, il singolo non veniva onorato per le sue gesta individuali, ma come parte di un progetto superiore in difesa della patria.
Inequivocabilmente, il notevole intervento artistico di Sindoni è rappresentato dal gruppo scultoreo che, come in molti monumenti ai caduti presenti in Italia e in Germania, evidenzia il tema iconografico del giovane seminudo in stile classico, simbolo di una virilità “
Nel contempo, significative risultano le tendenze stilistiche della scultura italiana dove il classicismo rinascimentale si sovrappone alla corrente neoclassica o confluisce nel filone di ricerca naturalistica. Quindi, la scultura tende alla monumentalità, alla retorica celebrativa e alla mitizzazione eroica, utilizzando un linguaggio figurativo tradizionale perchè il significato dell'opera diventi più comprensibile e di facile lettura per il popolo.
Nel caso specifico, il gruppo scultoreo è organizzato secondo uno schema compositivo piramidale, formato da due figure, una in posizione verticale e l'altra supina.
Il personaggio all'impiedi rappresenta un giovane eroe seminudo che impugna con la mano destra la spada per difendere la bandiera, simbolo della patria. In basso, invece, in posizione orizzontale è presente un altro giovane seminudo che stringe a sé, con la mano sinistra, l'estremo lembo inferiore della bandiera.
La nobile e pacata postura del personaggio alzato si rifà ai modelli della statuaria classica in cui vengono esaltate l'estetica e la proporzione del corpo, mettendo in evidenza la perfezione delle componenti anatomiche attraverso la nudità. Riscontriamo, ugualmente, l'ideale di perfezione estetica nella figura in basso, caratterizzata da una decisa muscolatura.
Nello stesso tempo è presente una delicata nota di realismo ottenuta dal dolce dinamismo dei corpi e dall'accurata espressione dei volti; la profonda verità è colta nello scatto in avanti del giovane armato, dall'espressione coraggiosa e fiera, e nella posa artificiosa e dinamica della figura in basso, in cui i muscoli sembrano essere in tensione. Il panneggio della bandiera, elemento scenico fondamentale dell'intera composizione, mette in relazion
Per quanto riguarda il quartiere barocco di Ibla, nel cuore del giardino ibleo, è presente un altro monumento ai caduti, realizzato negli anni '30 e attribuito al geometra Giuseppe Pinelli.
Sappiamo che un documento d'archivio del comune, datato 1927, riporta una somma da destinarsi per la sua eventuale costruzione, citando come direttore dei lavori l'ingegnere e architetto Carmelo Arezzo. Il monumento fu concepito come una sorta di “collinetta” su pianta quadrata, in cui al centro di ogni lato si aprono quattro gradinate, mentre negli angoli troviamo delle pareti rocciose dove sono incisi i nomi dei caduti. I gradini vanno a convergere in un livello superiore dove si erge un cippo funerario in stile eclettico, arricchito da decorazioni e da una corona d'alloro che circonda la scritta “pro patria”, mentre nei quattro angoli prendono posto dei pilastri decorati che fungono da paletti per l'illuminazione.
L'altro monumento ai caduti, datato 1927-1931, è quello presente a Marina di Ragusa.
L'opera si mostra nella sua semplice imponenza attraverso una composizione formata da un basamento sul quale poggiano due gradini e un alto piedistallo rivestito in pietra calcarea in opus incertum.
Al di sopra di questo si eleva un rilievo roccioso nel quale sono presenti quattro piccole targhe in pietra con i nomi dei caduti. Termina l'intera struttura una monumentale ancora in ferro, simbolo di salvezza. Oggi, dopo quasi un secolo dalla vittoria dell'Italia (4 novembre 1918), i monumenti ai caduti sono diventati i manufatti artistici di un'epoca che non c'è più, vestigia di una generazione sfortunata che dovette sopportare la carneficina della Grande Guerra, ma, anche, architetture della memoria che ci inducono a “non dimenticare”. Come affermava il teorico e scrittore d'arte F. Milizia, “la vita del morto sta nella memoria del vivo”.










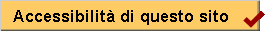
Aggiungi questo link su: